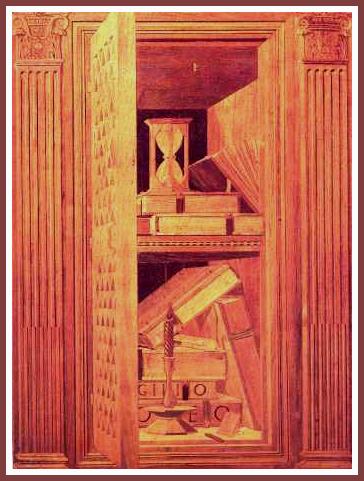
SCAFFALE D'AUTORE
Scaffale d'Autore è una scelta di brani letterari sulla Puglia, apparsi sull'inserto culturale del sabato del quotidiano di Foggia "L'Attacco". Proponiamo alcuni testi significativi.
PRIMA PUNTATA
IL PROGRESSO ALLA ROVESCIA
Inauguriamo questa nostra rubrica, dedicata ad una scelta di brani sulla Capitanata, con lo scrittore sanseverese Nino Casiglio (1921-1975), che ha pubblicato quattro romanzi, tra cui "Acqua e sale", del 1977, edito dalla Rusconi, che ha vinto il Premio Napoli. Il brano che segue è tratto dalle pagine conclusive del romanzo, in cui Donato Marzotta, il contadino protagonista, si spegne in ospedale, con il rimpianto di chi ha visto cambiare quello che doveva restare, mentre è rimasto quello che doveva cambiare. Una lezione attualissima, che mette in discussione lo sviluppo che il Sud ha avuto negli ultimi decenni.
La febbre non se ne andò; a Donato pareva di essere in campagna, accaldato, su una strada solitaria, e di vedere persone e cose note allontanarsi da lui, facendosi più piccole, tutte, anche i figli, anche Agata. Ad un tratto non vide più la parete di fronte e gli altri letti; vide invece, appoggiato alla ringhiera verdolina, Nicoletti, che lo guardava col suo viso per metà attento e per metà distratto, e gli parlava. […]
«Mi dispiace che il bilancio sia magro. La tua casa è sempre lì, non finita; i figli ti sono lontani, ciascuno a suo modo. Il mondo va da sé, e tu sei fuori della corrente. Non è questo che volevamo. E diciamolo, che siamo stati vinti. Anche se è sgradevole ammetterlo, ora che vincere è di moda, magari soltanto un disco o una lozione per capelli. Ma è una fortuna, forse, che tu sia rimasto nel tuo angolo morto. È l’antica storia del formaggio e delle pere; ma in fondo che ti sei perduto, continuando a mangiare pane e pomodoro? Patriarchi decadenti che fanno tavolata, con attorno nuore e nipotini brutti; nobildonne di cartapecora, con cataratta e visierina di celluloide; giovanotti byroniani con foulard; il solito principale con la segretaria; la solita vistosa con l'accompagnatore giovane; la gente che usualmente s'incontra al ristorante. La tua è una piccolissima provincia nella provincia; ma tutto il mondo è provincia, una miriade di province, una sfera ripartita da infiniti piani, un'arancia, una melagrana. E per tutti, presto o tardi, viene il momento di accorgersene, di sentire il richiudersi della vita, come di certi fiori quando hanno finito la loro giornata. Più presto o più tardi; molti giocano su questa differenza, sulla speranza che il loro turno tardi a venire, che il cerino non si spenga tra le loro dita. Non hai perduto troppo. Anzi, ti sei salvato. Ti sarebbe piaciuto andar lontano, come tuo figlio? O diventare come l'altro tuo figlio, l'ultimo anello di una catena di gente occupata a guardarsi intorno e a copiarsi a vicenda? Non sarei capace di consolarti, se si trattasse di farlo. Ma quello che io dico con le parole, tu lo puoi vedere da te senza di esse. È sgradevole, ma è. Prima, tu credevi di avere sotto gli occhi il tuo nemico; ora sai che il nemico è da per tutto, è anche in chi ti vuoi convincere che hai vinto, quando non hai vinto; che hai più potere, quando sei libero di imitare i vizi e le fisime di tanti altri. Avevo imparato che cambiare il mondo significava far rientrare l'uomo in se stesso. Siamo lontani, mi pare, da questo cambiamento. […] Per me, è cambiato quel che doveva restare, è rimasto quel che doveva cambiare».
SECONDA PUNTATA
LA TERRA DEL MIRACOLO
Ci sono dei luoghi che sembrano naturalmente predisposti al miracolo, anche prima che esso si verifichi. Uno di questi luoghi è sicuramente San Giovanni Rotondo, e più in particolare il convento dei cappuccini. Quando il forlivese Antonio Beltramelli vi giunge, nel 1905, il convento era un ospizio di mendicità e Padre Pio era ancora di là da venire. Ma il miracolo era già nell’aria. Il passo che segue è tratto dal primo capitolo de Il Gargano, che in prima edizione è del 1907, un capolavoro assoluto dedicato alla nostra terra.
Giungo al convento dei cappuccini, distante due chilometri, forse, da San Giovanni, che il crepuscolo arrossa i cieli. Il convento sorge in un breve pianoro prossimo alla cresta dei monti; è tutto cinto di cipressi e di roveti.
Il piazzale è deserto. Sotto due querce s’innalza, sopra una base a tre gradi, un’antica croce tutta nera nell’ombra; accesa a pena, lungo la sagoma, dalle lontane luminosità del mare. E’ un grande silenzio, una pace che invade e suade il core a raccoglimento; vicino e lontano, tutto è deserto intorno, tutto riposa quasi converso alla mistica calma di questo eremitaggio. Due cavalli brucano al limite del piazzale, sotto le querce; paiono grandi, scolpiti sui cieli. La scena ha una dolcezza di sogno. La chiesa è senza luci, su le piccole porte chiuse si aggrovigliano erbe e rovi, erbe e rovi selvaggi che l’antico spirito di Giano ha tratti su quella soglia dalla forza terrestre pel suo antico impero aspro e giocondo. Tutto è lindo e bianco; non v'è traccia del tempo; un pallido candore è su queste vecchie mura.
Picchio sommessamente alla porta sconnessa che conduce al convento, sommessamente, quantunque non oda un fremito, un sussurro, il lieve stormire di due foglie; ma, che so, qualcosa come un’idealità stanca e soave, come il sospiro di mille dolori, il pianto dell'umanità che si inciela, è nel mio cuore; qualcosa che sento in questo luogo lontano cinto di cipressi, dove si volle la pace, dove si volle Iddio. Noi, figli della vertigine, sentiamo con tanta dolcezza i riposi claustrali!
Nessuno risponde; mi pare avvertire lo strisciar lieve di un passo, ma è un inganno dei sensi troppo intenti all'intesa forse, poiché la porta non si dischiude. Rinnovo più volte il tentativo di richiamare l'attenzione di qualcuno, inutilmente. Ad un tratto odo due voci lontane, che risuonano come sotto un'ampia volta di tempio, due voci gravi che non mutano tono e si diffondono in tutto il silenzio e ne traggono echi, vibrazioni; è tutta una solitudine remota che si risveglia a quel suono. Io ascolto e non vedo; l’immagine mi significa due vecchi monaci, gli ultimi nella grande casa muta del sogno e della pietà. […]
Come faccio per ripartire, un monello che appare in una balza, mi indica una porticina secondaria per la quale si può accedere al convento. Un vecchio mi serve di guida. Tutto è vuoto ed oscuro all’interno; ma tutto è all’ordine e conservato a maraviglia; le anguste celle, i cortili, i peristili, i corridoi, il refettorio, la chiesa. I monaci non vi sono più; l'ultimo che v’era rimasto è morto da molti anni, ma tutto è là dentro per attestare della vita loro, tutto serba una traccia, un ricordo della semplice esistenza scomparsa.
Nelle antiche celle si ricoverano ora i vecchi e le vecchie mendicanti; aspettano laggiù l’ora fatale, rassegnati e sereni, l’ora che verrà con l'alta ombra dei cipressi a cercare l’anima errabonda. E pregano di minuto in minuto, d’attimo in attimo; dal convento al cimitero è breve il tragitto.
TERZA PUNTATA
VERSO IL GARGANO
Cesare Brandi (1906-1988), è stato uno dei più grandi storici dell’arte del Novecento. Teorico del restauro, docente universitario, ha pubblicato anche numerosi libri di viaggio. Una tra i più belli, “Pellegrino di Puglia”, del 1960, è dedicato proprio alla nostra terra. Il brano che segue, intitolato “Verso il Gargano”, mostra un campione esemplare della scrittura arguta e nitida, estroversa e precisa, con la quale il viaggiatore fissa un angolo del paesaggio di Capitanata, prima di salire sullo Sperone.
Al momento della partenza, l’automobile non intese di muoversi. Non potei non pensare alla iettatura. Con quanti viaggi ho fatto in Puglia, questa esplorazione del Gargano s’era vista sempre bruciata all’ultimo momento: o non avanzava più tempo o pioveva. Questa volta era la benzina che non passava. L’autista incaponito, punto sul vivo come fosse stata colpa sua, nazzicava febbrilmente a capo all’ingiù. Io facevo i cento passi col mio collega, fingendo un’indifferenza che mi rendeva anche più nervoso. I cento passi furono presto mille, duemila: gli argomenti in comune, rivoltati da tutte le parti, non davano più nessun suono: e la macchina era sempre ferma. Sapevo paventavo il momento che avremmo dovuto spingerla. Arrivò puntualmente, e puntualmente scaturirono due ragazzi volenterosi – per null’altro si scomoderebbero – con i calzoni zuava tirati fino alle caviglie, che li fa parere piccioni con le calze. Si correva, ma il motore non si accese. Fu allora la volta di farsi trainare. Il tassinaro interpellato chiese mille lire, per rimorchiarci ad una rimessa che era a due passi. Il mio collega dette in escandescenze. Per buona sorte una macchina di Milano si fermò e surrogò gratuitamente il tassinaro venale. Evocato dall’ombra, si avanzò verso la preda il ragazzo del meccanico. Ma la macchina non volle assolutamente muoversi, e fu necessario l’“elettrauto”. […] Si rividero le stesse viti, gli stessi tubicini: ma poi fu trascinata una grossa batteria, e, con questa prepotenza, la scintilla fatale sprizzò. Catarroso, ingolfato, scoppiettante, il motore prese l’abbrivio. Erano già le undici: metà del giro si trovava compromesso. Mentre, per fortuna o dispetto che fosse, la nebbiosità di prima s’era dileguata, e un sole sguainato falciava giovanilmente la strada, la rendeva lucida, rotabile, ma come se scorresse da sé sotto le ruote.
La campagna, livellata dalla bonifica, si stendeva di qua e di là, verde di un grano maturo appena spuntato, e solo di rado qualche filare di carciofi rigogliosissimi. Era una campagna, come in genere quella del Tavoliere, che è campagna al minimo, quasi senza alberi, quasi senza un cespuglio, ondulata lentamente, come a volte la sabbia. Il sole la rendeva ancora più sgombra, e così aperta procedeva con la nostra medesima velocità: sembrava, tanto uguale a se stessa, che non se ne lasciasse mai nulla indietro. Anche i casolari della bonifica, identici, sembravano sempre lo stesso, che ci corresse avanti dopo essere stato lasciato indietro, come fanno i cani.
Ma quando si cominciò a vedere le falde azzurrognole del Gargano, improvvisamente, contro quell’argine grandioso, la campagna scorrevole si arrestò. E ci si fermò anche noi: s’era a San Leonardo di Siponto.
QUARTA PUNTATA
L’EX VOTO DI SAN MATTEO
Tra i racconti di Riccardo Bacchelli spicca quello intitolato “Agnus Dei”, ambientato in Capitanata, tra la pianura del Tavoliere e le aride montagne del Gargano. Il quadro iniziale, che presentiamo, prende spunto da un ex voto del 1923 effettivamente conservato nel convento di San Matteo. Il protagonista, Matteo Mancino Di Dio, vivrà una vita errabonda e senza regole, per poi chiudere i suoi giorni, pentito, a San Leonardo di Siponto.
Al fonte gli era stato imposto il nome di Matteo, che gli giovò quando all’età di dodici anni fu addentato da un ciuco intiero di grande statura, magro come la rabbia e la lussuria e la vecchiezza che l’avevano scarnito sotto il basto e fra le stanghe, sotto il sole e fra la polvere del Tavoliere. I denti lunghi e gialli erano arrivati all'osso del braccio, a metà fra gomito e spalla; e le legnate a ruota pareva che servissero soltanto a levar la polvere dalla schiena affilata dell'animale, e a fargli stringere vie più le mascelle.
Allora intervenne San Matteo, protettore della rabbia degli animali, a disserrare quei denti, quando anche l’osso del bambino cominciava a sgretolarcisi.
La scena si vede dipinta in un ex-voto, dove il sangue umano spiccia al naturale e la ferocia ciuchesca è parlante. Pende con altri molti nel convento di San Matteo sopra San Marco in Lamis. Vi si vedono i bastoni levati e i bastonatori sulla strada dove il fatto avvenne; il padrone del ciuco molto più sollecito che non abbiano a sconciargli l’animale, che non delle urla del bambino; e San Matteo da una parte in una cornice di nuvole. Dall’altro canto del cielo, in una rosa di visi d’angioli, appare colei che non manca mai nelle opere misericordiose. Il ciuco schiavarda la spada di Sansone, e le legnate si fermano in aria. Molti bastoni rotti al suolo mostrano quante gliene avevan già date inutilmente.
Ma nel quadro non potè entrare il seguito. Il padrone del ciuco, un contadino duro come il suo animale, pretendeva d’essere rifatto dei danni, e voleva due pecore dal padre di Matteo, pastore. Diceva essergli stato sconciato l'asino, il più bello d'un'annata che al mercato d’animali in Cerignola non se ne vide l’uguale mai più; e che la colpa era del ragazzo, passato troppo vicino alla bocca del somaro.
Vociavano sotto il sole in mezzo di strada fra le pecore indifferenti e il ciuco, che in effetti aveva sbassate le orecchie e tremava sulle gambe stecchite. Matteo, fasciato con tela di sacco dal fratello maggiore, smise di gridare al veder l'avido contadino avvolger le mani entro i velli delle due più grasse pecore; andavano appunto a Foggia per la tosatura delle lane; e si ribeveva, il ragazzino, le lacrime, al veder mettere mani aliene nel gregge, e sgranava gli occhi. Chi non sa farsi valere non faccia il pastore, sulle strade e per valli e montagne senza difesa né ragione, se non se la fa lui.
Il contadino, se non fuggiva alle prime, ne prendeva quante il suo ciuco; e Matteo gli tirò anche lui la sua sassata, col braccio sinistro che gli serviva all’uopo da quanto il destro.
Il nome della famiglia era Mancino Di Dio; e s’incontra in Capitanata, ma che cosa significhi, se protezione particolare di Dio, o scherno antico, o ricordo di braveria e furfantaggine del primo che lo portò, o condizione di nascita particolare, non saprei.
QUINTA PUNTATA
LA MORTE DI ETTORE FIERAMOSCA
Il romanzo di Massimo D’Azeglio, “Ettore Fieramosca”, contiene un riferimento finale al Gargano. Edito per la prima volta nel 1833, ha goduto nel tempo di un grande successo, ma oggi ci sembra molto più citato che realmente letto. La parte che segue, compresa nella “Conclusione” del romanzo, riferisce l’episodio della morte del protagonista (che in realtà chiuderà i suoi giorni in Spagna, dieci anni dopo). Fieramosca, dopo il trionfo nella celebre disfida, scopre che l’amata Ginevra non è più tra i vivi, vittima della violenza esercitata su di lei dal Valentino.
[Fieramosca] Voltò dietro l’altare, e scese. Il suono delle sue armi, degli sproni e del puntale della spada che batteva sui gradini fece volger quelli che formando un cerchio empievano la cappella; s’aprirono: ai piedi si trovò il cataletto che avea visto la mattina nella sagrestia di San Domenico: in faccia accanto all’altare era Fra Mariano in rocchetto, stola da morti, e col braccio levato, teneva l’asperges; in mezzo, un avello aperto, di qua due uomini che ne tenevan ritta la lapide, di là Zoraide ginocchioni, curva sul corpo di Ginevra che era già dentro, e singhiozzando le componeva il velo intorno al volto ed una corona di rose bianche sulla fronte.
Ettore giunto al basso, vide, stette immobile, senza mandar una voce, senza far un atto, senza batter palpebra: il suo viso a poco a poco s’affilò, divenne pallido come la morte […]
Fra Mariano venne a lui, gli prese la mano, che ebbe senza resistenza, l’abbracciò, lo volse per farlo uscir di colà, ed Ettore obbedì. Saliron la scala, usciron di chiesa; duravano i lampi, i tuoni e l’acqua a secchie. Quando furon presso la foresteria, si sviluppò Fieramosca dalle braccia del frate, e prima che questi potesse quasi profferir parola, era già in sella curvo sul collo del cavallo, fittigli nella pancia gli sproni; ed il galoppo sonava sotto il portone della torre.
Né gli amici di Fieramosca, né uomo nessuno di quell’età lo vide mai più, d'allora in poi, né vivo né morto.
Si fecero varie congetture sulla sua fine; tutte però vane ed incerte. Una sola poté presentare un tal che di verisimile, e fu questa.
Alcuni poveri montanari del Gargano, che attendevano a far carbone, raccontarono ad altri villani (e così da bocca in bocca dopo molto tempo corse la voce in Barletta, quando già s’era levato il campo spagnuolo), che era loro comparso, una notte d’un gran temporale, una strana visione d’un cavaliere armato a cavallo sulla cima di certe rocche inaccessibili, che stavano sopra un burrato cadente a piombo nel mare: cominciarono a dirlo pochi, poi molti, poi alfine tutti dissero e tennero per fermo fosse stato l’arcangelo San Michele.
Quando però lo seppe Fra Mariano, e venne a confrontar l’epoche, pensò invece potesse essere stato Ettore, che fuor di sé, spinto il cavallo in luoghi difficilissimi, alla fine fosse caduto con esso in qualche ignoto precipizio, e forse anche nel mare.
Nel mille seicento sedici, essendo rimasto a secco un tratto di una scogliera sotto il Gargano, ad un pescatore venne veduto incastrato fra due pietroni un ammasso di ferraglie quasi interamente rose dal salso marino e dalla ruggine, e vi trovò fra mezzo ossa umane, e il carcame d’un cavallo.
Ora il Lettore pensi ciò che gli par meglio, ché la nostra storia è finita.
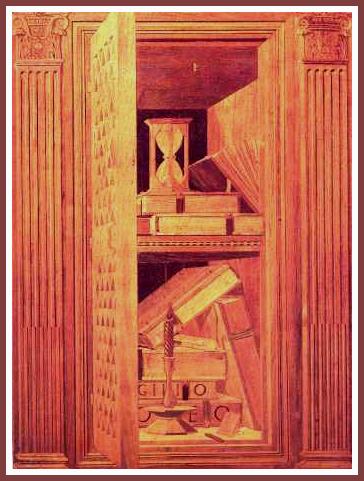
SESTA PUNTATA
IL GARGANO, TERRA GRECA
Guido Piovene (1907-1974) pubblicò nel 1957 un imponente e fortunato volume, “Viaggio in Italia”, che in mezzo secolo è stato ristampato a più riprese. Meticoloso, preciso, Piovene passa in rassegna tutte le regioni. Affascinato dalla Puglia, si mostra attratto dalla varietà dei suoi paesaggi e delle sue genti, scrivendo delle pagine memorabili, come quelle che seguono, dedicate al Gargano, accostato ad un lembo di terra greca.
Ma la grande bellezza turistica della provincia è il Gargàno. Promontorio montuoso, intorno al quale la letteratura è scarsa in paragone alle sue attrattive, e che perciò conserva qualche segreto, mi è apparso diverso da quello che le descrizioni altrui mi avevano prefigurato. Pensavo ad una montagna selvatica, scura, aspra, tendente all'orrido; mi sono trovato davanti ad una delle terre più greche d’Italia, nel senso del grazioso e del lieve. Con l’aiuto della stagione, vedevo un paesaggio dolce, fiorito, quale si incontra nei greci più lirici; coi mandorli metà bianchi di fiori e metà verdi di foglie, i greppi ricoperti di ireos selvaggi di colore violetto, e i gruppi degli olivi contorti sopra la roccia. Anche i villaggi, dalle case basse e intonacate a calcina, erano di una pulizia luminosa. Gli asini e i muli, le pecore, le capre nere attraversandoli spiccavano su quel bianco, e andavano ad abbeverarsi a fontane di marmo da poema cavalleresco, ricchezza di paesi poveri e fino a ieri isolati dal mondo. Nel mezzo delle strade le donne lavorano a maglia, e i banditori portano le notizie e le ordinanze del Comune. Un’aria classica, civile, per antichità […] è una terra di contadini, pastori e pescatori. Si pesca lungo tutta la costa, fino al golfo di Manfredonia, e nelle isole Tremiti al largo; in quei paesetti marinari, splendenti e scarni, che sono Peschici e Vieste. Leggera è anche la Foresta cosiddetta umbra, non si sa bene se in memoria degli umbri, antichi abitatori di queste terre, o solamente perché è ombrosa; posta in alto sul monte, unico avanzo delle foreste che coprivano il promontorio. Vi predomina il faggio, albero chiaro, ma vi crescono l’agrifoglio e il tasso venefico; ed è popolata di uccelli, folta ma senza orrore.
Sul Gargàno si accavallarono, lasciando ciascuna un deposito, genti diverse di passaggio. La preistoria, la Grecia, Roma e il Medio Evo vi lasciarono i loro segni, non tutti ancora messi in luce. Nelle Tremiti, belle e poco note, secondo la leggenda fu sepolto Diomede. Il santuario di Monte Sant’Angelo fu il più famoso nel Medio Evo. Mitologia pagana, magia, devozione cristiana si confusero in modo pressoché inestricabile. Il Gargàno poi cadde in un oblio quasi totale, da cui solo ora si solleva. Agricoltura e pastorizia vi danno poco reddito. Squisita la pesca, e ricca di pesce pregiato, oltre ad anguille e capitoni nei laghetti costieri; ma condotta ancor oggi con sistemi artigiani, senza trasporti organizzati, tanto che si è dovuto talvolta ributtare il pescato a mare. Questa situazione provoca forti malumori politici che contrastano stranamente con il grazioso arcaismo ambientale. Il turismo potrà alleviarla quando il Gargàno sarà conosciuto di più. Lo amarono soprattutto viaggiatori stranieri, più curiosi degli italiani delle bellezze rare e di una vita primitiva, in cui mitologie diverse sembrano continuare a vivere.
SETTIMA PUNTATA
“COME PUOI LASCIARE SANSEVERO?”
Il più grande critico della letteratura italiana, Francesco de Sanctis, fu per ben nove anni, dal 1866 al 1875, deputato del collegio di San Severo. Egli si ricorderà sempre della città dell’Alto Tavoliere, che lasciò per rappresentare il collegio del suo luogo nativo, Morra Irpino. Ai suoi vecchi elettori dedicò il “Viaggio elettorale”, apparso in volume nel 1876; l’ultimo capitolo di questo libro, dal quale è tratto il brano che presentiamo, si intitola per l’appunto “Sansevero”.
Non mancavano di quelli che mi dissuadevano. Ma non vedi come ti hanno accolto? Il collegio nativo è non dove s’è nato, ma dove s’è stimato. Come puoi lasciare Sansevero? E io sempre a rispondere: è il mio dovere. […] Intanto mi venivano lettere da Sansevero affettuosissime di amici provati, ma non senza inquietudine, e mi rammentavano le promesse solenni. E sissignore, rispondevo io, sarò costà. Volevo, approvata l’elezione, andare io là, esporre il caso, farli giudici essi medesimi, non dubitavo del loro assenso. Ma il disegno mi fu rotto. Si sparse colà la notizia della mia scelta, prima che ci andass’io. Non venite, mi fu scritto, qui ci è una vera indignazione; sarete ricevuto male, e non ci è rettorica che vi salvi, perché in fin dei conti le parole sono parole, e il fatto è che ci abbandonate. Rimasi trafitto. Ma mi posi la mano sul cuore, e dissi: soffri, il dovere non si fa senza soffrire. E deliberai di andarci, persuaso che la mia presenza avrebbe messo fine a tutti i malintesi. […]
Il dì appresso, sparsasi notizia del mio arrivo, vennero a salutarmi tutti, in pochi o in molti, come si accozzavano per via. Di tutto si parlò, fuorché di quello che era nell’animo di tutti. Discorsi freddi, cerimoniosi. Volevano farmi sentire il loro dispiacere, ma come suole gente educata, ne’ modi piu’ delicati. Raccoltomi co’ più intimi, traboccai, spiegai, m’animai, mi commossi. Era facile persuadere amici bravissimi, che desideravano d’esser persuasi, confidenti da lungo tempo nella mia sincerità. Il punto era persuadere gli altri. E ci tenevo moltissimo, non volendo che rimanesse alcuna ombra sul mio carattere.
Seppi che quei di Torremaggiore desideravano di vedermi, e mi proposi di andarci subito. Torremaggiore è un grosso comune a breve distanza che aveva votato quasi unanime per me, come aveva fatto Sansevero. Tutt’i signori del luogo mi vennero incontro e mi accompagnarono alla casa comunale. Visi aperti e ridenti, come di gente che godeva a vedermi, e a sentirmi parlare e a parlarmi. Tutto animato, ritrovai la mia espansione, e m’abbandonai a dir loro tante cose, le più affettuose e le più delicate. Amici miei, conchiusi, voi che amate tanto questa bella vostra patria, non potete biasimare me della mia scelta. Restituitemi la parola data, rendetemi la mia patria.
L’accoglienza avuta a Torremaggiore si sparse a Sansevero e vi fece buon effetto. I dubbii, le cattive prevenzioni si andavano dissipando, e più tempo passava e meglio era. Il tempo è davvero un galantuomo e non ci è menzogna che regga a lungo contro di quello. Quando andai alla casina, ci trovai già altr’aria. Mi parlarono di Rocchetta, e uscì a taluno questo delicato pensiero, che accolto con quell’entusiasmo a Rocchetta dovevo trovar fredda l’accoglienza avuta a Sansevero. Se ne scusavano, la spiegavano. Voleva persuadere un persuaso.
OTTAVA PUNTATA
IN AUTOMOBILE PER LA CAPITANATA
Carlo Placci, nato a Londra nel 1861 e scomparso a Firenze nel 1941, scrittore e giornalista, ha pubblicato nel 1908, per i tipi della Treves, un singolare libro di viaggi, intitolato “In automobile”, ristampato nel 2005 dalla Carabba di Lanciano. Tra i vari capitoli, uno riguarda la nostra regione, “In Puglia”, ricco di osservazioni stravaganti ed interessanti. Di certo, l’automobile per molti pugliesi era davvero un oggetto sconosciuto, e di qui le loro reazioni.
Per le strade maestre incontriamo contadini d’ambo i sessi litaniando a due per due col bordone ornato di coccole di pino: una brutta imagine li precede: ogni quando un loro caporione agita un campanello. A voltarsi indietro, il nostro polverone ne fa un quadretto fumoso. Qualche volta sono cavalcate intere di romei rurali: i somari, taluni caricando marito e moglie insieme, s’impennano, e avviene un fuggi fuggi confuso di mantelloni e cappelli da cospiratori spagnuoli, di gropponi ciuchini, di “tovaglie” da testa femminili... Piú spesso sono “traini” o “sciarabbà” che renderebbero la società protettrice degli animali più idrofoba delle bestie che protegge. In due soli muli, coperti di finimenti lustranti, trascinano una media di venti persone che gestiscono, cantano, urlano allo stesso tempo. Sono terrorizzati, e con ragione, dal nostro incontro, sopra tutto per la salita di Monte Sant’Angelo, perché i vetturini non sanno guidare, e i muli ombrano, indietreggiano, girano, minacciano di prendere la mano, finiscono per puntare le due alte rote contro il parapetto che li separa dal precipizio. Fa spavento vederli... Ma, grazie a San Michele, il pericolo imminente è scongiurato: il nostro chauffeur fa un fischiettino magico che ammansa istantaneamente gli animali, mentre, per tranquillare i pellegrini, il burlettante della nostra comitiva, nascosto dagli occhialoni e dal cappuccio, quindi simile a un confratello di congregazione molto contemporanea, disegna un gran gesto benedicente assai ieratico, dicendo lentamente, con fantastico accento meridionale: “Niente pagura, fradelli! U Santo è con noi!!!” E così la macchina, senza altri incidenti fino al prossimo, procede professionalmente, buttando appena una manciata di polvere dentro a quelle bocche attonite, alla volta salmodianti e blasfemanti...[…]
Dopo Cerignola abbiam tagliato in due un “tratturo”. È l’estremità del medesimo tratturo che ho visto un anno fa negli Abruzzi, dritto su pel monte, come un’ampia strada di parco?... La sopravvivenza di queste vecchie vie armentizie, coi loro “riposi” laterali, mi colpisce sempre. […] È un paesaggio malarico, con odore di padule e di asfodeli biancastri. Ora ora Siponto e Manfredonia ci hanno prodotto un’impressione così mesta e abbandonata! Tra gli scogli, vicino a Manfredonia, tutti quei fichi d'India impolverati, rigidi come coralli verdognoli, davano una inesorabilità dura al paesaggio... Di qui, la striscia stessa del mare è troppo lontana per dare movimento, animazione: appena col cannocchiale distinguo, solitaria sulla spiaggia, una di quelle torri di difesa contro i corsari antichi. È forse abitata adesso da finanzieri che hanno la febbre?... Il pensiero di dover tornare a Foggia ci opprime. Non esclamerò mai mai mai col poeta ducentista: "Puglia Piana... Là dove è lo mio cuore notte e dia”...
NONA PUNTATA
LE PROMESSE TRADITE DELLA VITA
Quello che vi proponiamo stavolta è l’attacco del famoso romanzo di Mariateresa Di Lascia “Passaggio in ombra”, vincitore del Premio Strega nel 1995. Una vittoria postuma, visto che la scrittrice, nata a Rocchetta Sant’Antonio nel 1954, si era spenta prematuramente il 10 settembre dell’anno prima. In quest’opera, ricca di pregi artistici e con qualche difetto, la protagonista, l’infelice Chiara, diventa la dolente denuncia delle promesse non mantenute della vita.
Nella casa dove sono rimasta, dopo che tutti se ne sono andati e finalmente si è fatto silenzio, mi trascino pigra e impolverata con i miei vecchi vestiti addosso, e le scatole arrampicate sui muri scoppiano di pezze prese nei mercatini sudati del venerdì. Ormai sono libera di non perderne neanche uno, e ho tutta la mattina per stare in mezzo alle baracche a rovistare a piene mani, fra stoffe colorate e sporche che qualcuno, per sempre sconosciuto, ha indossato tanto tempo fa.
Stamane, per esempio, ho trovato delle camicette bianche con i fiori rosa di cotone vero, come non ne fanno più, e sono felice mentre apro l’acqua nella vasca da bagno e le metto a schiarire con il disinfettante.
Hanno cercato di convincermi in molti a lasciare questa casa, perché è piccola e affogata e, quando mi viene l’asma, rischio sempre di morire davanti alla finestra aperta, ma io non dò ascolto a nessuno, e penso che è inutile preoccuparsi di ogni cosa: la morte verrà quando verrà e nessuno ci potrà fare niente. Mi porteranno via, per queste strette scale dei palazzi moderni, e avranno un gran da fare per svuotare tutto il ciarpame che è stato la mia vita.
Da ragazza mi vestivano come un’attrice del cinema, e io guardavo il mondo con i miei occhi di pupa di pezza, lunghi e ricciuti come le ali di una farfalla. Nessuno si accorse mai che l’occhio destro era completamente cieco per una macchia che mi era venuta fin da bambina, contro la quale non hanno saputo fare nulla neanche i medici che poi ho incontrato nella vita.
Avevo i capelli biondi e una testa leonina che si faceva guardare quando camminavo, immersa nei miei pensieri, e le macchine si fermavano bruscamente per non travolgermi sulla strada.
Ho vissuto in ogni città di questo paese e non ho potuto fermarmi mai, inseguita com’ero sempre dai mille mostri atroci della mia fantasia. Sono andata pellegrina di strada in strada, di casa in casa, cambiando pure i bar dove mi piaceva prendere il caffè della mattina, perché non trovassero le mie tracce. Le tracce dei miei racconti di principessa esule su questa terra senza anima, dove i miei polmoni hanno trovato difficile perfino respirare.
Forse ero nata per un grande destino, ma questo lo sapevano in pochi: donna Peppina Curatore, che mi era zia, e Anita, mia madre. Francesco, mio padre, deve averlo vagheggiato anch’egli, ma solo per vanità.
Quando donna Peppina, che mi ha amata più di ogni cosa al mondo, e per questo mi rubò a mia madre e mi mise sempre contro di lei, decise che avrei studiato, e sarei diventata una “professorona”, avevo dodici anni e stare al mondo non mi appassionava, perché l’umanità pulsa di desiderio e di passioni incontrollate e forti, che io non so provare e neanche immaginare e che, infine, mi terrorizzano.

DECIMA PUNTATA
IL GARGANO COME QUINTESSENZA
Fu Michele Vocino il primo che parlò del Gargano come quintessenza delle bellezze dell’Italia, ma questo lusinghiero accostamento è diventato noto grazie ad un elzeviro del rondista Antonio Baldini (1889-1962), apparso sul “Corriere della sera” nel 1925 e poi confluito, con il titolo “Peschici”, in “Italia di Bonincontro”, che in prima edizione è del 1940. Indubbio esempio di prosa d’arte, lo scritto contiene dei passi davvero incantevoli e degni di considerazione.
Che ne direste, se invece della grande Italia allungata da N. a S. pei viaggi di nozze coi grandi Espressi, vi dessi, come voi chiedete, una minuscola Italia di prova, che andasse invece da O. ad E., ancora «nuova per queste scene » e senza la più piccola traccia di strada ferrata? Una piccolissima Italia, ancora inedita, quintessenziata, con degli abitanti sui generis, con un Appennino e dei laghi tutti per lei, e con un assaggio assai compendioso e istruttivo (sopra una lunghezza di settanta e una larghezza di quaranta chilometri circa) del colore e delle caratteristiche di paesaggio e di cultura di molte, se non di tutte, le altre terre italiane di maggiore spicco: voglio dire con un poco di Liguria e un poco Sicilia, un poco d’Istria e un poco di Toscana, un poco d’Umbria e un poco di Calabria, un po’ di Capri e un po’ di Ciociarìa? Che ne direste? […]
Pensate dunque che bellezza! una piccola Italia così poco conosciuta dagli stessi italiani che anche tra le persone colte molti non sanno, facendo il suo nome, dove lasciar cadere l’accento; una vera piccola Italia ricca di boschi, di storie, di santità, di leggende, della quale il Baedeker non dice nulla e probabilmente lo stesso Alinari s’è dimenticato. […]
Un’ora di mulo vi fa salire, dalla regione dei fichi d’India, dove abbondano i capperi sulle mura arroventate dal sole, a quella delle carboniere nelle gole umidissime del monte. Una mezz’ora di carrozza vi trasporta dalle agrumifere terre ancora profumate dalla canzone di Mignon alla rada turchina delle ecloghe pescherecce del Sannazaro. Una corsa a ruota libera in bicicletta, per ottime strade, attraverso pascolo e foresta, vi fa riuscire, giù da un grigio e scorbutico villaggio di Schiavonia nella piazza deserta e abbagliante d’un paese tutto arabo sul mare. Gli ulivi che accuratamente coltivati per tutto un fronte di colline fanno tornare a mente certi dolci aspetti dell’Umbria francescana, per poco che salga la costa voi li vedete uscir di terra grandi e selvaggi come quelli del gebel tripolitano. […]
Paese incrostato di storia più di qualunque altro; ma con questo di buono, che lì la storia non fa più rumore di quanto ne possan fare nei meriggi estivi le onde del mare e le fronde del bosco: e quando tutto tace anch’essa tace e schiaccia il pisolino dell’erudito locale nella libreria senza pretese. I monumenti che ci sono cercano di non farsi vedere o spuntano con tutta discrezione da un verde di giardini profumati. Per lo più sono vecchie torri alzate un giorno invano sul litorale contro i pirati turcheschi che desolarono a varie riprese la regione, e che ora, rimbiancate di calce, servono d’alloggio alle guardie di finanza. Potete fidarvi, signore. Qui la storia non abbaia e non morde. Sonnecchia.
UNDICESIMA PUNTATA
LUCERIA SARACENORUM
Il celebre arabista Francesco Gabrieli (1904-1996) nacque a Roma, ma era figlio di uno studioso di Calimera, in provincia di Lecce, e non dimenticò mai il suo legame con la Puglia. Tra i testi che ha dedicato alla nostra terra c’è “Volti e Uomini di Puglia” (Congedo, Galatina, 1974), in cui è compreso il brano “Luceria Saracenorum”, di cui riportiamo la parte iniziale.
Amo la verde pianura di Capitanata, che mi dà ogni volta il primo saluto della Puglia materna, all’affacciarmici dall’Appennino. L’amo per le grandi memorie imperiali che vi aleggiano intorno, per il sospiro nostalgico di Enzo re che a lei tornava col cuore dalla prigionia di Bologna, per l’immagine onnipresente del gran Federico, cara alla nostra giovinezza ghibellina. Più a sud, in terra di Bari, la potenza sveva ha lasciato il suo maggior monumento, e Foggia, la “Fogia regalis” che mi è apparsa come ringiovanita dopo i terribili colpi della guerra, fiorente d’una vigorosa e decorosa ripresa edilizia, serba ormai appena una traccia della sua regale corona […].
Ho corso appena Foggia, per rivederne la deturpata Cattedrale, e il semidistrutto arco imperiale. E ho proseguito per la vera meta di questa mia rapida gita, l’ancora a me sconosciuta Lucera, sveva e saracina; Lucera che ha ispirato le pagine di illustri periegeti e turisti, dal Gregorovius al Lenormant e al Bourget, dall’Ungaretti al Bacchelli. Sesto io no ma postremo fra questi e tanti altri visitatori insigni, un solo titolo potevo accampare che a loro tutti mancava, una certa familiarità con quei Saraceni trapiantati qui di Sicilia, che scrissero il più curioso e drammatico capitolo della storia lucerina, e screziarono d’una pittoresca vena d’esotismo l’avventura sveva nel nostro Mezzogiorno. Per un arabista, la visita a questo angolo d’Italia ove risonò per l’ultima volta, l’anno del primo Giubileo, l’appello alla preghiera dei muèzzin, aveva una suggestione tutta particolare; e ciò anche ben sapendo che quasi nessun ricordo da parte araba ci resta di quell’episodio, ricostruito a suo tempo dall’Egidi su documenti latini (periti ormai anch’essi purtroppo, nel rogo bestiale dell'Archivio napoletano, il tristo settembre del ‘43).
M’ha iniziato ai monumenti e alle memorie di Lucera l’odierno suo genius loci, il modesto e valoroso avvocato Gifuni, in cui quel titolo professionale sembra quasi una stonatura rispetto alla sua vera professione e passione, di storico e indagatore del natio loco, inquadrante la cronaca regionale nel vasto orizzonte della grande storia, l’arte il folclore l’aneddotica locale in una ricca e soda cultura filosoficamente educata, da degno discepolo saraceno di don Benedetto. […] E anzitutto, mettendo piede a Lucera, cominciamo col rendere omaggio al re del luogo, che non è Federico né Manfredi né Carlo lo Zoppo, ma Ruggero Bonghi, giustamente onnipresente nel ricordo dei suoi quasi concittadini (egli nacque casualmente a Napoli, da vecchia famiglia lucerina, e a Lucera fu sempre provvidamente vicino): “Bonghi” è la Biblioteca civica, “Bonghi” il Liceo, a Bonghi il monumento presso il bel San Francesco. L’ometto in palamidone, dalla testa rotonda e dalle ricche fedine ottocentesche vi viene incontro a ogni piè sospinto a Lucera, nelle pietre e nella parola evocatrice della dotta guida.
DODICESIMA PUNTATA
QUEL GIORNO DEL 1956
Emanuele Italia, nato a Camerino, nelle Marche, nel 1927, ma ormai pugliese di adozione, ha pubblicato numerosi testi letterari, di non comune valore. Nella raccolta “Dialoghi e diavoli”, edita dalla Bastogi di Foggia nel 1999, c’è un racconto, “Sud”, in cui Italia rievoca il suo arrivo, nel 1956, a San Severo, da poco nominato docente di ruolo di filosofia. Nel brano scelto per l’occasione, ritroviamo il tema, antico ma sempre suggestivo, del contrasto tra Nord e Sud.
Stefano ci ha provato a capire. Benché fosse incline piuttosto alla poesia e alla pittura che non alle questioni storiche, sociali, psicologiche e politiche, non si era negato ai tentativi di penetrare una realtà nella quale bruscamente era piombato da centinaia di chilometri lunghi cent’anni. Ma aveva capito? Ne dubito e anche lui ne dubita. Ma (si era domandato) è possibile capire - capire davvero - quelli di cui non si siano condivise esperienze, timori, aspettative, amori e odi e le minute quotidianità che ci amalgamano in un tutto di cui ci sentiamo partecipi?
Stefano se lo ricorda, se lo ricorda spesso quel pomeriggio di mezzo settembre quando, sopraffacendo lo stridio dei freni, l’altoparlante annunciò: “Stazione di San Sebastiano, stazione di San Sebastiano”. Sceso dal treno e percorso il sottopassaggio, si trova sul piazzale della stazione, ha ancora la testa frastornata dagli sballottamenti e gli occhi colmi di pali che s'inseguono sullo sfondo d'un mare fisso e stanco, d’un turchino come di zaffiro morto. Il paesaggio sempre più piatto, sempre più piatto, dall’orizzonte appena smosso dalla calura che intorbida l’aria, di là dalla massicciata che costeggia la ferrovia, è rotto da cespugli inselvatichiti, da campi crepati da fenditure che sembrano piaghe, da zolle che rovesciano al sole le loro pance glabre e gialle. A Stefano erano venuti in mente Cechov e la steppa. Ma ora finalmente è arrivato.
Arrivare significa toccare uno scopo, adempiere un destino, talvolta avere successo. “E questa la mia meta, qui s’arena il mio destino, è questo il mio successo”, si argomenta Stefano. Si passa la pesante valigia da una mano all’altra e gira intorno lo sguardo. Nessuno. Gli ultimi viaggiatori si sono già dileguati. Un viale alberato impigra sdraiato sotto una cappa d’inerzia silenziosa, le foglie non danno fruscio, l’afa morde l’asfalto. Laggiù in un rigoglio trionfale di rosso e di azzurro, macché, in uno sfacelo di sangue sgozzato e in un osanna di ametiste sfibrate, s’eleva la cupola d’una chiesa ricoperta da scaglie verde-oro. Sfolgora, pare crogiolarsi come lucertola al sole ebbra di sonno. Stefano è affascinato e atterrito. All’improvviso una zaffata acre di non so che tanfo, un'esaltazione di putrefazione gli azzanna la gola. Non c'è nemmeno un tassì. Un cavallo dal buco del cappuccio lo guarda. Anche il vetturino seduto a cassetta lo guarda. I due sguardi lo colgono in flagrante mentre si preme il fazzoletto al naso. “Volete la carrozzella?” Stefano è interdetto, quel calessino arcaico col mantice che gli sembra un’alcova proibita e quell’uomo con la frusta infilata nel foro di un tubicino di ferro, gli fanno l’effetto di un ironico fantasma sbucato da una fiaba dimenticata. Si decide. “Mi porti in un albergo che non sia troppo caro, ma decente".
TREDICESIMA PUNTATA
EROS E MISTERI NELLA LUCERA DELL’OTTOCENTO
Raffaele Vescera ha riproposto nel 2006, per i tipi dell’editore foggiano Grenzi, il suo fortunato romanzo “Inganni”, ambientato a Lucera nell’Ottocento, in cui si racconta la storia d’amore del giovane barone Nicola Scassa per la bella principessa Lauretta Zunica. E’ un romanzo di notevole rilievo, che guarda con attenzione alla storia, ma riesce anche a rendere il fascino di un amore sensuale alimentato dal mistero e dal pericolo. Di qui un brano tratto dall’inizio del quinto capitolo.
Settembre, con un po’ di frescura, mi donò un nuovo incontro con Lauretta in occasione del suo diciottesimo compleanno. Non potevo mancare alla sua festa. Ottenni l’invito, e ne approfittai per nascondermi nello stanzino delle scope per la seconda volta. Avvisata Lauretta, uscii puntuale all’una dal nascondiglio raggiungendo la porta dei miei pericolosi richiami. Con le ansie a malapena scemate, grattai come un gatto, ma non aspettai molto.
Posando l’occhio sul buco della serratura, vidi la vergine apparire con la camicia spiegata sul davanti. La ninfa mostrava ingenua la sua nudità, ne ebbi quasi tumulto nel vedere le sue gambe di gazzella. Non ero novello spettatore di nude donne assortite, ma ogni brano del corpo di Lauretta era un profondissimo pozzo di inabissamento delle mie passioni.
La bella figliola aprì senza esitazioni. Attraversammo per la seconda volta la camera del nostro panico e tenendoci per mano entrammo nella stanza virginale.
Deciso a ben festeggiare il suo diciottesimo compleanno, snudai con un sol colpo la sbigottita fanciulla della sua leggera camicia da notte. Ella, nuda, fu di nuovo tremante. Il piatto del suo ventre, al lume di candela, luccicava liscio, mentr’ella copriva, pudica con le mani, il suo seno di giada. Non aggredii quell’angelo. La contemplai, piuttosto stupito ed estasiato da tanta fisica superbia.
Le infilai al collo il mio dono. Una collana con cammeo, portata da mia madre. Con sinuose carezze le mie mani seguirono le curve del suo corpo. La sentivo fremere al contatto delle mie dita, la vergine si faceva morbida e cedevole. Liberandomi dai miei panni, le svelai i misteri del mio corpo maschio, e l’avvertii paga nel constatare il vigore delle mie segrete membra.
Ci contorcemmo smaniosi in interminabili danze pagane, ma senza esito. La ninfa respinse i miei ripetuti attacchi al suo vergine fiore, acerbo bocciolo di bruno tulipano serrato tra le bianche colonne delle sue gambe. Rassegnato ai ripetuti dinieghi, iniziai a farla sapiente dei satireschi misteri delle mie membra gagliarde. Ella imparò presto a donarmi il piacere con i mezzi più diversi.
Ci scambiavamo ancora, con fioca voce, tenerissime parole d’amanti, quando giunse il primo sole, invadente di luce indiscreta e rivelatrice. Guardavo in tutto il suo splendore il corpo di Lauretta. Sul fondo della schiena, che aveva forma di violoncello, mi avvidi di due fossette graziosissime che vezzeggiai come giocondo fanciullino.
Al mattino, mi obbligò a rifugiarmi nel tabernacolo. Ne uscii indolenzito ed arruffato a mezzodì e, raggiungendo indenne la grande anticamera, mi sgolai a chiamare don Cecchino. Non udendo risposta alcuna, discesi lo scalone guadagnando il cortile.
QUATTORDICESIMA PUNTATA
IL PENSIERO POMERIDIANO DI ENZO VERRENGIA
Tra i libri dello scrittore sanseverese Enzo Verrengia “La notte degli stramurti viventi” (Besa, Lecce, 1996, poi Stampa Alternativa, Viterbo, 2001) ha una sua spiccata personalità. Usando una lingua iperbolica ed iperespressionistica, l’autore ha offerto un incisivo ritratto del Meridione. Quello che riproduciamo, è l’attacco del primo racconto, “Il pensiero pomeridiano”, dall’evidente e voluto riferimento alla celebre opera di Franco Cassano.
Qua, se dobbiamo parlare di macchine, dev’essere solo di Biemmevvù e Mercedès. Asserzione colta nel Tavoliere.
Il fegato non dà solo coraggio, ma anche sonno, dopopranzo. E visto che al sud la pennichella persiste anche nel terzo millennio, si potrebbe avanzare l’ipotesi che la questione meridionale sia soprattutto epatica. Il sonno pomeridiano induce a credere che faccia notte due volte al giorno, tanto da produrre una diversa concezione del tempo, percepito con un trascorrere più lento, per l’esattezza con un ritmo dimezzato rispetto a quello naturale. Si spiegherebbe così il ritardo nello sviluppo.
Ma allora perché invece il meridione si adegua rapidamente a livelli di vita perfino più avanzati di quelli svedesi? In una media città del sud si vedono più cellulari che a Stoccolma, più Mercedes e BMW che a Berlino e più lattine di Coca Cola che a New York. Il commercialista tipico di questi paraggi non si contenta più della settimana bianca a Passo Lanciano, a Madonna di Campiglio, a San Martino di Castrozza o perfino a Saint-Moritz e Kitzbühel: lui va direttamente ad Aspen, in Colorado, il paradiso degli sciatori improvvisati, quelli che puntualmente si schiantano contro i pini, arrecando gravi darmi all’ambiente. Quanto alle gite balneari, le splendide e soleggiate spiagge locali vengono disertate con un’arricciatina del naso per escursioni alle Maldive, alle Seychelles e alle Galapagos.
Da dove viene tanta ricchezza se il pomeriggio si dorme?
Resta sempre la mattina, per lavorare. Tuttavia in quelle ore d’ufficio si nota un affollamento sospetto di bar, piazze e altri luoghi di relax come sale da biliardo e circoli. Eppure l’età media dei frequentatori è ben lungi da quella della pensione. Ancora più inquietante è lo sfoggio di capi firmati e orologi da quotazioni in borsa, mentre i media strombazzano dati apocalittici sulla povertà al sud. Quindi permane il mistero di un benessere apparentemente fondato sul nulla. Qual è la sua origine? La risposta viene spesso dalla magistratura e dalle forze dell’ordine, specie la Finanza. Non si parla solo di attività dichiaratamente criminali, dove la natura del reato appare subito riconoscibile. Metti il contrabbando, di sigarette, di carne umana, viva e trapiantabile, di armi e bagagli. Al campionario del crimine in chiave classica, contemporanea e futuribile, si sommano comportamenti difficili da tacciare a prima vista come illeciti. Contributi pubblici utilizzati per accrescere il parco auto personale, contatti con i politici non finalizzati alla discussione ideologica, fatture gonfiate, prestazioni superpagate, traffici con l’altra sponda, balcanica, dove le opportunità fioriscono per chi crede che la parola scrupoli sia solo adatta al nome di una boutique. Con tanto daffare, per forza c’è bisogno di dormire due volte al giorno. Un sud, dunque, non rallentato bensì affaticato dall’iperattività che esige la new economy.
QUINDICESIMA PUNTATA
LA PUGLIA DI GIOVANNI MARIOTTI
Nel 1928 a Roma, per i tipi della Società Editrice di
“Novissima”, viene pubblicato un interessante volume dedicato alla nostra
regione, intitolato “Nostalgie di Puglia”. L’autore è Giovanni Mariotti,
nato nel 1900 e scomparso nel 1964, che legherà il suo nome a molti testi
sul turismo come, ad esempio, “L’Italia turistica”, del 1929.
Mariotti, che non va confuso con altri due
omonimi, il senatore e studioso di Parma (1850-1935) e l’ancora vivente
scrittore e firma del “Corriere della Sera”, collabora nel periodo in cui
nasce il libro pugliese con l’ENIT, l’Ente Nazionale Industrie Turistiche. I
suoi interessi resteranno costanti fino alla fine, facendo di lui un esperto
di notevole livello, come dimostrano anche i vari manuali sul turismo da lui
firmati e utilizzati nelle scuole.
“Nostalgie di
Puglia”, che si fregia della prefazione di Luigi Rava, consta di quasi 300
pagine e contiene un ritratto lusinghiero e rimarchevole della regione
prescelta. Mariotti, come si legge al termine del capitolo introduttivo,
intitolato “L’altra Italia”, si propone di contribuire “ad una più diffusa
conoscenza della Puglia e d’indurre gli italiani delle altre regioni a
visitarla”. Il suo punto di vista è quello di un “Settentrionale sempre
vissuto nel Settentrione”, come scrive lo stesso autore, che ha molta
considerazione per il Sud. Stranamente, malgrado i tentativi, non siamo
riusciti a conoscere moltissimi dati sulla sua vita né tanto meno sulla sua
nascita (nel repertorio di Luca Clerici, “Viaggiatori italiani in Italia”,
si parla di Cagliari). In ogni caso, egli non è pugliese di origini.
Il suo viaggio copre i vari ambiti territoriali, dalla
Capitanata al Salento, seguendo la consueta direttrice da Nord a Sud. I
primi due capitoli, dopo quello introduttivo appena citato, sono “Foggia e
Lucera” e “Il Gargano”. Da questi, in due diverse puntate, prenderemo ampi
stralci, che mostrano le sue non comuni qualità di scrittore.
La prima puntata ci mostra proprio Mariotti attraversare il
Tavoliere per dirigersi verso Lucera, sulle tracce di Federico II, tra
memorie storiche e squarci paesaggistici.
FOGGIA E LUCERA
Un breve tronco ferroviario unisce
Foggia a Lucera. Così quest'antica cittadina è comodamente e rapidamente
accessibile. Ma non con la ferrovia l'ho raggiunta. Ho preferito percorrere
la vecchia strada provinciale in automobile, per passare proprio nei luoghi
che videro gli avvenimenti più emozionanti della storia pugliese.
La bianca via
si allunga drittissima sull'immensa distesa del Tavoliere. Ai lati sono
gl'immensi campi pianeggianti, ormai falciati, sui quali si stende ancora il
giallo abbronzato delle stoppie. In qualche fattoria le macchine
trebbiatrici strepitano ed alzano in aria copiose colonne di fumo.
Corriamo vicino ad uno di quei tratturi che furono le prime naturali
comunicazioni della Regione. Nessuno li tracciò; furono i greggi a segnarli
venendo a svernare e tornando dopo il facile pascolo alle verdi pendici dei
monti d'Abruzzo. E tuttora servono a questo scopo. Migliaia di pecore e di
buoi scendono ogni anno in questa verde pianura, seguendo le strade secolari
che i pastori conoscono perfettamente per averle percorse fin da fanciulli.
E in maggio tornano rifacendo il cammino inverso, con lenti viaggi che
durano intere settimane.
Nell'immensa pianura non si alza un albero.
Qualche ciuffo d'erba seccata dal sole è sui cigli della strada e nel grande
tratturo. All'intorno i campi si stendono perfettamente piani, senza
cespugli, senza case, smisurati; e si crederebbero abbandonati da secoli se
non si sapesse che proprio qui cresce quel grano che Foggia custodisce nelle
grandi “fosse” del sottosuolo.
Di qui dové passare Manfredi quando cercava di
guadagnare Lucera, per riunire le forze dell'Impero ed umiliare una volta
per sempre i baroni ribelli.
Questo ed altri ricordi di Manfredi - il figlio naturale e prediletto
di Federigo II - mi tornano in mente mentre l'automobile corre sulla strada
bianchissima risalendo i dolci pendii che scendono
da Lucera. E mi
sembra che tutta la pianura - inconscia testimone di tante turbinose vicende
- riviva la vita di un tempo, com'essa si disegna e si muove nella mia
fantasia.
Non è la Lucera Saracenorum che mi accoglie allorquando traverso la bassa porta ogivale che incontra chi viene da Foggia. Le strade abbastanza larghe, le case recenti, i negozietti alla buona non sono dell'antica città. Questa che vedo per prima è la Lucera Cristianorum, insignificante e sciatta continuatrice di quella Lucera Saracenorum che fu per tanti anni una delle città più famigerate, qualcosa di demoniaco nato dall'eresia federiciana, la “spina fitta nell'occhio della chiesa”, come ebbe a dirla Innocenzo IV. Lucera cristiana è una delle tante cittadine meridionali, senza una particolare fisonomia, senza attrattive, piuttosto povera e disadorna. E in nulla ricorderebbe la sua tragica storia dugentesca se non conservasse il vecchio duomo, mirabile chiesa gotica innalzata da Carlo II d'Angiò per commemorare quella carneficina di Saraceni che si volle far passare come una grande vittoria del Cristianesimo sull'Islamismo.
Ma non sono gli angioini che Lucera ricorda ed esalta. […]
In ogni modo non questa Lucera moderna e borghese io cerco; ma l'altra Lucera, quella che bisogna vedere se si vuol conoscere una delle pagine più emozionanti della storia dei maomettani in Italia. Essa è fuori della città, di fianco al grande giardino ch’è pur esso un formidabile spalto sull'immensa distesa del Tavoliere.
Non si può giungere sotto le vecchie mura
dell'antica Lucera senza
sentir gravare su noi sette secoli di storia e specialmente quella degli
anni turbinosi che andarono dalla costituzione della colonia saracena
all'orrenda carneficina voluta dagli
Angioini. Questi ricordi
non balzano da un'esaltazione alimentata dalla conoscenza - del resto
imperfetta - di quel mondo lontano che i più non conoscono e che forse non
capirebbero se si accingessero a studiarlo. La vita dell'antica Lucera è
nelle sue stesse pietre, è nelle grandi torri del castello diroccato, balza
dalle mura rovinate, si alza dal solenne silenzio del grande piazzale
circondato ancora dalle torri e dalle mura, è imposta all'attenzione del
visitatore dall'alta solitudine che circonda le rovine e fascia di mistero
questo venerabile ed oltraggiato monumento dugentesco
Non
è stata la fierissima
potenza delle torri e delle mura che si allungano sul lato del pentagono che
guarda la città - dov'è ancora, profondo il fosso - a commuovermi di più!
La fortissima torre della Leonessa, quella meno potente ma bella del Leone,
l’ingresso che ancora sembra guarnito dell'antica saracinesca sono opere di
vera e grande bellezza, che esercitano un fortissimo fascino su chi si reca
a visitarle. Ma una commozione ben più profonda ho provato allorché sono
entrato nell'interno del diroccato castello.
Le porte
erano chiuse, il custode assente. Perciò dovetti scavalcare, non senza
pericolo, un alto cancello e calarmi lentamente dall'altra parte.
Sul terreno sommosso, dove sembra che tutto sia stato
distrutto e ammucchiato appena da ieri, quasi con la paura di non riuscire
in tempo a compiere l’opera nefasta, più nulla è rimasto. Anche l'erba
seccata dal gran sole è stata bruciata; ed ora il terreno sembra
carbonizzato.
E' qui, nell'alta solitudine di queste accigliate rovine che la terribile storia del vecchio castello rivive. Per questo una sosta fra le mura diroccate, i mucchi di ciottoli e le torri è di un fascino che non si sa ridire.
Qui, dove tutto è distrutto
gli arabi eressero le loro casematte e le loro moschee e tanto crebbero di
numero e di potenza che vi costruirono un'intera città, la quale straripò
sulla più antica Lucera fino a impossessarsene del tutto; gli abitanti
fuggirono e il duomo fu convertito in moschea.
[…]
Nell'alta solitudine e nel silenzio profondo
che circondano questo tragico castello e i campi smisurati che esso domina,
sembra che debbano riprendere
vita e movimento le grandi figure storiche che qui vissero nei secoli
lontani. E nulla può avere una potenza evocatrice come queste vecchie rovine
e la piana sulla quale si affacciano. Roma risuscita dai campi insanguinati
di Canne, le invasioni barbariche dei Goti e dei Longobardi sono rievocate
dalla lontana marina di Siponto alla quale essi approdarono per muovere alla
conquista di queste terre, la mistica epopea delle crociate, l'eroica
avventura normanna, l'agitatissima vita degli Svevi, il tragico passaggio
degli Angioini, le dominazioni degli Aragonesi e degli Spagnoli: tutta una
storia di secoli e secoli è rievocata con i suoi episodi di sangue e di
bellezza, fino a sgomentare ed opprimere.
Dai nuovi giardini la vista del castello saraceno è
completa e magnifica. Mi sono fermato a lungo, vicino a una croce, per
poterla godere. E poche volte ho provato tanta commozione come quando ho
veduto, in tutta la potente poesia del suo rovinoso abbandono, questo
grandioso rudero di una città saracena che non esiste e non esisterà mai
più. La grande torre della Leonessa, abitata
soltanto dai falchi alza la sua mole massiccia nel cielo intensamente
azzurro, le cortine altissime si allungano interrotte dalle torri in rovina,
una porta ogivale lascia vedere un po’ del desolato interno. E tutta la
costruzione è ancora una minaccia sulla piana sottostante, che ha per ultimo
limite le ondulazioni dell'Appennino.
Lucera
Saracenorum non è una rovina desolata e morta; vive ancora nella sua fiera
bellezza e costituisce uno dei più emozionanti ricordi monumentali della
lunga e nobilissima storia pugliese.
SEDICESIMA PUNTATA
LA PUGLIA DI GIOVANNI MARIOTTI- 2
Continuando
nella pubblicazione di stralci da “Nostalgie di Puglia”, parliamo ora del
Gargano. Il libro, apparso nel 1928, per i tipi di un editore romano,
presenta numerosi motivi di interesse. Sulla sua copertina è riprodotto uno
dei disegni di Livio Apolloni che impreziosiscono il testo, dedicato a
Castel del Monte (da notare che un altro disegno, inserito tra le pagine 28
e 29, rappresenta il castello di Lucera). Nella copia in nostro possesso si
legge una dedica manoscritta, datata “Bari 22 febbraio 1929”, a firma di una
Natalia e di una Mariarosa, non meglio identificate, che ci sembra doveroso
riportare: “Con augurio e perché tu ci segua, un pochino, nella terra che ci
ospita”. A distanza di 80 anni, queste semplici parole, con la loro
intrinseca malinconia, ci sembrano davvero incantevoli.
Nel
secondo capitolo del libro, del quale ci occupiamo in questo numero,
intitolato “Il Gargano”, Mariotti descrive un Tavoliere quanto mai desolato
e solitario. Egli percorre in autovettura la strada che porta da Foggia a
Manfredonia e davanti a lui ci sono i segni della malaria e dell’ostilità
ambientale. Lo stesso complesso monastico di San Leonardo di Siponto appare
completamente abbandonato e in rovina, come lo vedrà in quegli anni anche
Riccardo Bacchelli, che ne trarrà ispirazione per il racconto “Agnus Dei”.
La
strada piatta conosce poi una brusca ascesa, portando a Monte Sant’Angelo,
l’antica capitale religiosa della zona, meta obbligata per ogni visitatore.
Qui la devozione è ancora caratterizzata da un anacronistico fanatismo, che
trova la ferma condanna di Mariotti.
Il ritorno vede lo scrittore ancora a contatto con il Tavoliere, “immenso e squallido, sotto il fulgido sole del mezzogiorno”. Lo scrittore-viaggiatore esclude dal suo tragitto la zona costiera del Gargano ed altri luoghi interni, come San Giovanni Rotondo, ed è un peccato, visto che avrebbe potuto aggiungere a quelle riportate nel capitolo in questione delle altre pregnanti notazioni. Nel terzo brano siamo già a Trani, oltre l’Ofanto.
IL GARGANO
La grande strada che conduce da Foggia a Manfredonia è deserta in questo primo mattino; non un’automobile, non un carro, non un passante. Il sole che si è alzato da poco già accende di vivissima luce la gialla distesa delle stoppie e dà al candore della strada riflessi violentissimi.
Non un albero si alza nell'immensa distesa dei campi; non una casa colonica ho veduto. E l'unica costruzione che incontra chi va da Foggia a Santa Maria di Siponto - eccettuati i vecchi ruderi di San Leonardo - è l'ambulanza antimalarica, modestissima casa ad un piano la quale ricorda al viaggiatore il flagello terribile che ancora martirizza la vita di questa vasta zona della provincia di Foggia.
Tanto più ci si avvicina a Manfredonia, tanto più lo squallore della grande pianura è evidente e penoso. La malaria ha spinto gli uomini verso le ubertose e salubri pendici del Gargano; e nulla dell'antica vita è rimasto in questa squallida e tristissima zona del Tavoliere.
Di questo squallore e di questa tristezza sono testimoni e partecipi le mirabili rovine di San Leonardo. Tutto decade e si sgretola in esse: la chiesa e l'abbazia. Anche il portale del fianco sinistro, così bello e ben conservato finora, minaccia d'irreparabile rovina. E già è caduto fra i ciuffi dell'erba alta il leone sul quale poggiava la colonnetta sinistra. Nei locali dell'abbazia sono ora alloggiati alcuni contadini. Ma quando vi andai, non una persona era presente. Il silenzio più alto circondava le vecchie mura; la chiesa era chiusa e nessuno all'infuori di me si aggirava nei vasti locali in rovina, alcuni dei quali sono stati trasformati in vastissime stalle. Purtroppo San Leonardo non è più che un ricordo, malinconico e squallido.
Maggiore malinconia è nelle antiche rovine di Siponto. Sembra impossibile che il floridissimo emporio dei romani ed uno dei primi vescovadi d'Italia si sia potuto ridurre così. Eppure, tanto ha potuto la malaria! Il Candelaro e il Cervaro impaludano la vastissima zona limitrofa al mare e lentamente hanno formato una delle più estese e micidiali zone malariche d'Italia. Per questo già nel dugento Siponto è resa inabitabile. […]
Manfredonia, che
successe a Siponto, sembra aver ereditato anche le sventure della
disgraziata città. La sua fisonomia attuale nulla conserva dell'antica,
all'infuori del forte castello angioino. E per quanto le strade siano ampie
e regolari come quelle di ogni altra città moderna, nulla può ricordare la
floridezza che Manfredi volle darle e che certo ebbe quando raccolse la
popolazione di Siponto. […]
Manfredonia e il suo unico monumento ispirano una grande malinconia. Ma quanta serena e gaia bellezza è nei dintorni della città, verso il Gargano! Man mano che la strada si avvicina alle prime colline, lasciando il mare a destra, la campagna assume una fisonomia nuova, molto diversa da quella della vasta pianura che circonda Siponto e si spinge fino a Manfredonia. I campi non sono coperti soltanto d'erbe e non si stendono a perdita d'occhio nella triste uniformità della piana. Appaiono invece lievemente ondulati e tutti ricoperti di fichi d'india, i quali crescono in tale quantità ed assumono tali proporzioni che a vederli dall'alto, nelle loro vaste distese, sembrano folti uliveti. La strada risale lentamente i primi colli, poi s'inerpica arditamente e con curve strettissime rimonta di groppa in groppa. Ogni tanto i forti muriccioli che la fiancheggiano s'interrompono; e ciò avviene nei punti in cui la nuova strada attraversa l'antica che ricorda i letti dei torrenti, tant'è ingombra di sassi. Monte Sant'Angelo è su, lontano, a guardarci dall'alto dei suoi ottocento metri. E su, nel Santuario di San Michele, è l'antico cuore religioso e storico del Gargano. […] La devozione della folla ha ancora manifestazioni di un fanatismo che impressiona. Alcuni pellegrini s'inginocchiano dinanzi al cancello esterno del Santuario, vicino all'alto campanile, e traversano il cortile così inginocchiati, spostandosi di pochi centimetri per volta sicché impiegano qualche ora per scendere la lunghissima scala e giungono nel Santuario con le gambe rotte dal dolore. Altri, e non sono pochi anche oggi, si trascinano carponi, leccando per terra, dall'ingresso per tutta la scala fino all'altare della grotta. Quando giungono alla fine dello straziante viaggio la lingua non è più che un brandello di carne sanguinolenta che impedisce di parlare. Molti si contentano di bere l'acqua miracolosa. Le stille che cadono dalla volta dell’umile grotta sono raccolte in una piccola cisterna dietro l'altare dell'Arcangelo e l'acqua viene distribuita in piccoli recipienti d'argento. Nessuno infine lascia il Santuario senza aver riportato quei bricioli di pietra che sono considerati come vere reliquie e vengono perciò forati per passarvi un filo ed attaccarli al collo dei bambini.
Certo i sacerdoti del Santuario fanno del loro meglio per evitare manifestazioni di fanatismo che nulla hanno in comune con gli atti di devozione. Ma nessuno ha mai potuto impedire che buona parte dei pellegrini invochi la misericordia di San Michele a suo modo, presentandosi dinanzi all'altare con le gambe rotte da un'assurda fatica o con la lingua martoriata da un ripugnante atto di ossequio.
Artisticamente, la celebre grotta non è di notevole pregio. E a parte la disposizione architettonica datagli da Carlo d'Angiò, il suo migliore ornamento è senza dubbio quell'antica sedia episcopale che è a sinistra dell'Altare e che proviene da Siponto. Sono piuttosto le memorie storiche e quel senso d'antico, così evidente in ogni parte della secolare costruzione, che danno al Santuario l'interesse e il significato delle opere monumentali. Tutto il resto è manifestazione di un fanatismo che non si sa come possa ancora sussistere.
Per uscire dalla grotta non ho salito la lunga scala coperta da volte ogivali, che avevo sceso dopo aver traversato il grande atrio. Sono invece andato sul balcone che corre intorno al cortile e di qui ho preso la ripida “Scala Santa” che passa sopra la volta del Santuario. I gradini sono così consunti che rimane appena un quinto del loro spessore e sull'unica parete (dall'altro lato la scala è libera) sono stati incisi innumerevoli contorni di mani, con i nomi dei pellegrini che vollero lasciare questo strano ricordo del loro viaggio.
Oh! la gioia del sole luminoso e caldo dopo le tenebre e il freddo della spelonca! Sono uscito dal Santuario con quel senso di sollievo che si prova quando ci liberiamo da un incubo; e dopo aver ammirato l'estesissimo panorama che si gode dall'alto campanile ho visitato la cosiddetta Tomba di Rotari, tanto nobile e fiera da sembrar veramente il più nobile sepolcreto di un Re.
Visitato Monte Sant'Angelo e non potendo proseguire per gli altri paesi garganici e per le selve che il promontorio tuttora conserva, ho ripreso la bianca strada che conduce a Manfredonia.
L'automobile corre col motore spento per chilometri e chilometri e dinanzi ai miei occhi passano le groppe dei monti sui quali i contadini hanno lavorato da secoli per formare modeste coltivazioni a terrazze. Poi le pendenze si fanno meno ripide, i monti digradano in colli ubertosi e già si affaccia la grande e verdeggiante distesa di fichi d'india che circonda la bianca Manfredonia.
Il Gargano è ben
presto alle mie spalle, lievemente soffuso di azzurro. E il Tavoliere di
Foggia mi appare di nuovo, immenso e squallido, sotto il fulgido sole del
mezzogiorno.